|
Nel
nome della Materdomini
fondazioni ospitaliere
medievali nell'agro nocerino-sarnese in Campania
di Orazio Ferrara
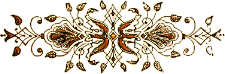
Si devono agli studi dello storico nocerino Michele De Santi
, che agli inizi del Novecento consultò le pergamene dell'archivio
del monastero di Materdomini, le notizie sulle fondazioni ospitaliere,
nell'agro nocerino-sarnese, dell'Ordine dei Monaci Bianchi, ramo
autonomo della più grande famiglia dei Frati Umiliati.
Quest'Ordine e l'Abazia di Materdomini, in cui esso è insediato
e dove si venera una pittura bizantineggiante di Madonna col Bambino
detta dal popolo la Sacra Cona, vengono fondati dal milite Pietro
Ferrara de Regina, che ne è anche 1° Abate generale
.
Nel tempo basso-medievale il minuscolo Ordine dei Monaci Bianchi
riuscirà a gestire ben tre ospedali nell'agro nocerino-sarnese,
ed è per questo che esso può essere considerato
a tutti gli effetti un vero e proprio ordine ospitaliero. Dei
predetti tre ospedali solo per uno, quello di Materdomini, si
può però parlare di vera e propria fondazione, mentre
per gli altri due, quello di Palma Campania e quello di San Giorgio,
quest'ultimo di epoca molto più tarda rispetto agli altri
due, si deve parlare di una rifondazione. Infatti, come vedremo,
gli stessi pervengono all'Ordine a seguito donazione dei dominus
di quelle universitas, i quali intendono così risollevare
le sorti dei loro ospedali, avviati ad una fatale decadenza.
Nei primi decenni del 1200, la gestione ospitaliera deve essere
stata cosa assai gravosa per i Monaci Bianchi, con i due ospedali
di Materdomini e di Palma (quello di San Giorgio, come accennato,
verrà più tardi, agli inizi del 1300), ubicati lungo
l'unica importante arteria, che da Capua porta a Salerno e quindi
nel sud d'Italia e che proprio nei pressi di Materdomini, ha una
diramazione che conduce ad Avellino, poi Benevento e quindi in
Puglia ai porti d'imbarco per la Terrasanta. In quel tempo il
flusso di pellegrini e crociati è numeroso e continuo in
quello strategico tratto di strada, che attraversa l'agro nocerino-sarnese.
A dare una mano ai pellegrini più bisognosi e malati soltanto
i Monaci Bianchi e i francesi Cavalieri di Sant'Antonio Abate,
quest'ultimi hanno una loro Commanderie con ospitale-hospitium
alla porta orientale della città di Sarno, la cui fondazione,
risalente alla seconda metà del XII secolo, è quindi
ancora più antica dell'analoga istituzione sanitaria di
Materdomini . Lo sforzo di questi frati ospitalieri, in termini
economici ed organizzativi, è davvero cosa di non poco
conto, basti pensare che la vicina, potente e già ricchissima
Abazia dei Benedettini di Cava procederà alla fondazione
di un proprio ospedale soltanto nell'anno 1262.
E' l'arcivescovo di Salerno, Romualdo II della nobile famiglia
salernitana dei Guarna, con la bolla "Ex debito pastoralis
officii", emanata il 9 novembre 1172, a riconoscere ufficialmente
il nuovo ordine monastico di Pietro Ferrara e a sottometterlo
all'osservanza della Regola di San Benedetto . Per alcuni cronisti
del Santuario è un successore di Guarna, Cesario vescovo,
a confermare nell'anno 1175 la regola benedettina e a prescrivere
che i frati indossassero "le lane virginiane", cioè
l'abito bianco simile a quello dei monaci di Montevergine, da
qui l'appellativo del popolo di Monaci Bianchi, e che noi useremo
nel presente lavoro per comodità di linguaggio.
L'Abazia di Materdomini diviene ben presto uno dei santuari
più famosi e visitati dell'Italia meridionale. Tra i pellegrini
si contano papi, re ed imperatori. Innumerevoli le donazioni nel
corso degli anni. Particolarmente munifiche quelle concesse dal
re Guglielmo II il Buono nel 1178 e dall'imperatore Federico II,
lo stupor mundi, nel 1220 .
La vocazione ospitaliera dei Monaci Bianchi dovette essere
presente fin dagli inizi, osservando quei frati scrupolosamente
quel passo della Regola, in cui San Benedetto, aveva disposto
la cura sollecita "infirmorum, infantum, hospitum pauperumque".
In un primo momento per soddisfare queste incombenze, ci si avvaleva
dell'officium infirmarie, collocato forse all'interno del monastero
ed affidato ad un monaco appellato per questo "Custos".
Abbiamo conferma dell'esistenza di questa figura da una carta
del 1226, come riporta il De Santi. Questa carta risale al tempo
in cui è Abate di Materdomini quel Pietro, secondo di questo
nome e la cui intelligente operosità per una sempre maggior
grandezza dell'Ordine lo avvicina a quella del primo Pietro il
fondatore, tanto che l'imperatore Federico II nel citato diploma
del 1220, ne decanta "honestatem celebrem vitam et religionem"
e lo dice "venerabilis abatis". Affianca questo Abate
Pietro II con le funzioni di Priore, al quale sono affidate l'amministrazione
e la disciplina del monastero, un certo Giovanni, che è
detto anche "custos infirmarie monasterii" .
Negli anni immediatamente successivi al 1190, si sparge la
voce che l'imperatore Arrigo VI di Hohenstafen, affetto da lebbra
o da una particolare forma di peste, sia stato guarito dalla sua
infermità durante una sua visita al Santuario di Materdomini.
Leggenda, miracolo della Sacra Cona o unguenti medicamentosi preparati
dalle abili mani dei monaci? Non lo sapremo mai. Però basta
questa voce a far sì che molti accorrano nel Santuario,
che si è rivelato non solo porto di salvezza per l'anima,
ma anche per il corpo.
Con l'andare del tempo il piccolo officium infirmarie del monastero
non riesce però a far fronte, in modo soddisfacente, alla
moltitudine di malati e di poveri, che si presentano di continuo,
imploranti aiuto, alla porta dell'Abazia.
E' il 4° Abate dei Monaci Bianchi, Silvestre, che regge
con mani ferme le sorti della comunità monastica dal 1191
al 1213 e che è detto, nelle carte di quel periodo, "Sacerdos
Monachus et Abbas Sancte Marie Matris Domini in Pede Rocce Apomontis",
ad addivenire alla decisione di procedere alla fondazione, in
Materdomini, di un ospitale, che sia nel contempo, come è
nella prassi dell'epoca, anche hospitium per i pellegrini.
Dunque, nell'anno Domini 1208, egli emette l'editto di fondazione
dell'ospedale, vincolando, per il suo funzionamento, tutte le
rendite e i proventi dei beni e dei censi appartenenti alla chiesa
di San Giacomo in Montoro . Questa chiesa e i suoi cospicui benefici
erano pervenuti all'Abazia di Materdomini nell'anno 1192, a seguito
di una donazione dei fratelli de Avella. Ben presto divenuta
Grancia, essa godeva delle rendite di molte proprietà,
non solo in Montoro, ma anche in San Severino e dintorni, e in
particolare in località Piazza di Pandola.
La persistenza dell'ospitale in Materdomini è attestata
per oltre due secoli, e dura fin quando sono presenti dei Monaci
Bianchi. Ancora nel 1380 si hanno lasciti di grosse somme
all'Abazia "pro beneficio Hospitalis favendo".
E' credibile la tradizione che vuole i monaci di Materdomini
tenere in perfetta efficienza il loro ospedale, se nell'anno 1236
il barone di Palma Campania, il milite Guglielmo de Castellone
o Castiglione, si decide a donare ad essi la chiesa e l'ospedale
di Santa Maria a Piè di Palma, con tutte le relative pingue
rendite . La donazione è fatta appunto per risollevare
le sorti di quell'ospedale, affidandolo a gente che si è
rivelata esperta nelle cose sanitarie.
Intorno all'anno 1310 Berardo de Sangiorgio, dominus di San
Giorgio e Casali, di Deliceto ed altri feudi, nell'istituire suoi
eredi la moglie Maddalena de Aquila e il figlio Berarduccio, ordina
a quest'ultimi di procedere alla fondazione di un ospedale nella
Terra di San Giorgio, esattamente nel suo compreso di case site
nel luogo detto "a la Barra". Dispone, altresì,
a favore dei Monaci Bianchi di Materdomini, col vincolo di collaborare
al funzionamento del suddetto ospedale, la rendita annua di dieci
once d'oro, da prelevarsi dalle entrate dei suoi beni in San Giorgio.
Ma già nel tempo medievale tenere in efficienza un ospedale
doveva essere cosa alquanto difficoltosa e dispendiosa, d'altronde
tutto poi era reso più complicato dalla presenza di una
co-gestione suddivisa tra la corte baronale e i monaci. Così
che, appena quattordici anni dopo, nell'anno 1314 donna Maddalena
de Aquila, ormai vedova di Berardo de Sangiorgio, le cui spoglie
mortali riposano per suo espresso desiderio nell'Abazia di Materdomini,
procede, davanti al notaio Nicola Sutore e al giudice annale Giovanni
Sforciato, ad una definitiva sistemazione a riguardo dell'ospedale.
Sono presenti, quali testimoni, diversi nobili, tra cui i baroni
Nicola e Guglielmo Budetta da San Severino e il barone Guglielmo
Pagano.
Nell'atto donna Maddalena dichiara che non solo ha eseguito
le volontà del marito, barone Bernardo, istituendo l'ospedale
"a la Barra", ma ne ha anche accresciute le dotazioni
economiche, previste in un primo tempo, con l'assegnargli i seguenti
altri beni: due terreni con case sempre "a la Barra",
confinanti con le proprietà degli eredi del nobile Gentile
Dallimanno, e molti altri terreni ubicati a Torello, a Piedimonte,
a "Pecia de Fore", a San Salvatore, "a lo Tergine",
"a li Costabili", "a la Sala", "a Sant'Eustasio",
"a la Chiusa", a San Felice, "a lu Plesco".
Aggiunge poi che per la devozione, che porta alla Sacra Cona di
Materdomini, è venuta nella seguente determinazione. Dopo
aver ottenuto il consenso del figlio, barone Berarduccio, e l'assenso,
tramite regie lettere, del Logoteta del Regno di Sicilia, Bartolomeo
de Capua, per quanto riguarda l'alienazione di diritti e proventi
feudali, decide di donare, come in effetti dona, l'ospedale con
tutti i beni sopra descritti e gli interi diritti e proventi del
feudo di San Giorgio all'Abazia di Materdomini, affinché
i Monaci Bianchi custodiscano l'ospedale ed assistano i malati
e i poveri. L'unica condizione posta è che l'abate protempore
di Materdomini, in segno di riconoscenza di questa donazione,
porti l'annuo tributo di due libbre di cera alla corte baronale
di San Giorgio nel giorno "Purificationis Beate Marie"
.
In quel torno di tempo è alla guida di Materdomini Matteo
(dal 1300 al 1316), 9° nella cronotassi degli Abati Bianchi.
Successivamente i monaci, adiacente all'ospedale di San Giorgio,
edificarono la chiesa di Santa Maria alla Barra ed un piccolo
monastero. L'intero complesso ospitaliero diventò quindi
Grancia dell'Abazia di Materdomini.
Nella scia della lunga tradizione di assistenza ai più
bisognosi, con cui si distingue per tutto il basso Medioevo l'Abazia
di Materdomini, è da collocarsi anche la fondazione in
quest'ultima di una Fratancia (confraternita di laici) detta di
Sante Marie Candelarum. Una pergamena dell'anno 1296 ci conferma
che la sua esistenza risale già a diverso tempo prima,
pertanto essa è una delle più antiche confraternite
laicali di tutta Italia, forse coeva a quelle romane .
Sigillo dell'Abazia di Materdomini e quindi dell'Ordine e di
conseguenza anche dell'Ospedale, fu sempre la figura della Madonna
in maestà, cioè coronata e seduta sul trono, con
in braccio il Bambino. La conferma si ha da un sigillo, descritto
dal De Santi, che lo ha osservato ancora integro su un diploma
di donazione del 1298 .
Il sigillo, in cera nera, è di forma ovale ed ha ambedue
i lati incisi. Dal lato principale (sigillo dell'Abazia) è
raffigurata la Santa Vergine in trono, che regge con il braccio
sinistro il Bambino seduto sulle ginocchia, il quale si aggrappa
al seno con la mano destra. A destra del trono è raffigurato
un giglio. Tutt'intorno la scritta: S. Marie Matris Domini.
L'altro lato (sigillo dell'abate pro-tempore) si presenta con
il campo partito. Nella parte superiore vi è il busto della
Madonna coronata e cinta di aureola, che regge il Bambino; nella
parte inferiore un abate inginocchiato con mitria e pastorale
ed un libro aperto fra le mani. Circonda l'intero campo la scritta:
Iohis Abbatis siggillum. La scritta ci dice che si tratta del
sigillo di fra Giovanni, 8° nella cronotassi degli abati e
2° di questo nome, che regge la comunità monastica
di Materdomini dal 1258 al 1299.
|
![]()
